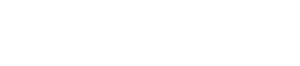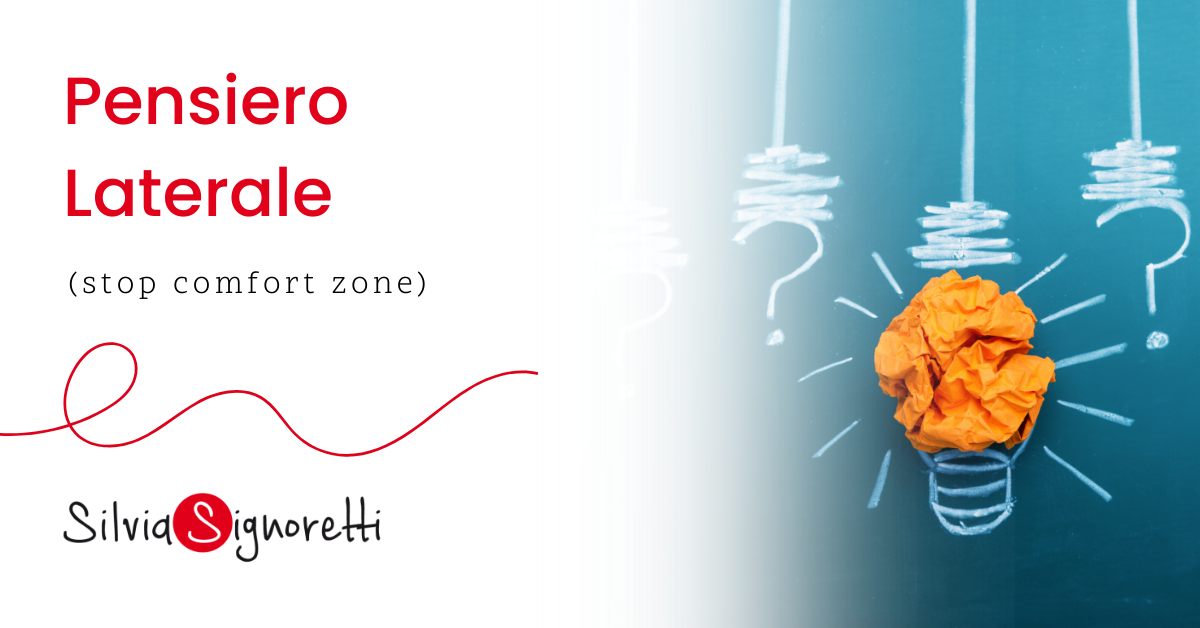
Pensiero Laterale: quando il cervello deve uscire dalla sua comfort zone
Cos’è il Pensiero Laterale e perché se ne parla tanto? Il Pensiero Laterale, insieme alla conoscenza di bias cognitivi e delle strategie emergenti della Facilitazione può essere uno degli strumenti chiave per ogni manager e leader. Aiuta i team di lavoro a operare meglio, sostiene processi complessi, stimola la creatività e rende meno estenuanti le vostre riunioni di lavoro. Un recente episodio in montagna mi ha fatto pensare a questo articolo per provare a mettere un semino di Pensiero Laterale nei nostri processi – sì, non sono immune al pensiero verticale – con suggerimenti su letture utili e qualche spunto di riflessione ed esempio storico. Buona lettura.
Prefazione: quando la vetta si raggiunge pensando “strano”
Durante le vacanze estive avevo una missione: un giorno in montagna, 700 metri di dislivello, gambe non proprio allenate, e due mete che mi erano rimaste nel cuore. Due cime vicine, entrambe bellissime, ma con un piccolo problema: nessun percorso online le collegava.
Tutti i siti di escursionismo le trattavano come due gite separate. Due montagne, due giorni diversi, due avventure distinte. Ma io avevo un solo giorno a disposizione e un’idea fissa: perché non vederle entrambe?
Così ho tirato fuori la cara e vecchia mappa cartacea dei sentieri CAI. Ho studiato curve di livello, numeretti dei percorsi, tempi di percorrenza. Ho tracciato una rotta che collegasse le due mete, creando di fatto un percorso che sui siti non esisteva.
La guida del CAI che ho incontrato in malga si è stupita: “Mai visto nessuno fare questo collegamento. Eppure ha perfettamente senso!” Ecco, quella frase me l’ha fatta riflettere per giorni.
Edward de Bono lo dice meglio di me: “Non puoi scavare un nuovo buco limitandoti a scavare lo stesso buco più a fondo.”
E allora ecco il punto: nel lavoro, nei progetti, nella vita, siamo tutti un po’ come escursionisti che cercano sempre il sentiero più logico. Ma cosa succede quando la strada più battuta non ti porta dove vuoi andare? Cosa fai quando il “buonsenso” diventa il peggior nemico della creatività?
TL;DR per chi ha fretta:
- Il pensiero laterale è la capacità di trovare soluzioni creative uscendo dai percorsi logici tradizionali
- Non sostituisce la logica, ma la precede: prima crei, poi organizzi
- Edward de Bono ha sviluppato tecniche concrete per “allenare” questa capacità
- Nel mondo del lavoro, può fare la differenza tra seguire i competitor e sorprenderli
Perché il nostro cervello ama le scorciatoie (e perché è un problema)
Il nostro cervello è un campione di efficienza. Ha sviluppato una capacità straordinaria di riconoscere schemi, creare automatismi e trovare la strada più breve tra A e B. È quello che Daniel Kahneman chiama “Sistema 1”: veloce, automatico, intuitivo.
Il problema è che questo sistema, pur essendo utilissimo per la sopravvivenza quotidiana, può diventare una gabbia dorata quando abbiamo bisogno di innovazione.
“È sempre spiacevole staccarsi da figure note che ci sono state ripetutamente utili: ci sentiamo molto impegnati con loro”, scrive de Bono nel suo famosissimo “Pensiero Laterale”. Questa frase descrive perfettamente il nostro attaccamento agli schemi mentali: ci sentiamo sicuri dentro i percorsi che conosciamo, anche quando non ci portano più dove vogliamo andare.
Pensate a quante invenzioni geniali sono nate solo per aver acceso il pensiero laterale, abbandonando (anche solo per qualche momento) la strada nota. Il velcro, i post-it, la penicillina, il microonde, ma anche la teoria della relatività di Einstein sono esempi ben noti di scoperte rivoluzionarie che non sono nate da un percorso usuale. Mi affascina moltissimo anche la meno nota storia della scoperta della cura per l’ulcera, la cui causa venne identificata nell’Helicobacter Pylori, che richiese uno sforzo immenso ai medici che ne portarono in luce l’esistenza… ma scopriremo questa storia in itinere, visto che ben si lega anche con il libro di Gianrico Carofiglio di cui abbiamo scritto qualche tempo fa in merito agli errori.
La Mappa del Pensiero Laterale secondo de Bono
Edward de Bono non si è limitato a teorizzare il pensiero laterale – ha creato una vera e propria cassetta degli attrezzi per svilupparlo. Le sue quattro strategie principali sono tanto semplici quanto rivoluzionarie:
1. Occhio a quello che dai per scontato
La prima trappola del pensiero verticale è partire da presupposti che sembrano ovvi. De Bono suggerisce di fare una lista di tutto quello che stai dando per scontato in una situazione. Spesso la soluzione si nasconde proprio lì.
L’aneddoto del sassolino bianco e della figlia del mercante
De Bono apre il suo libro “Pensiero Laterale” con un aneddoto illuminante. Un mercante ha un grosso debito con un usuraio che, invaghitosi della figlia del mercante, propone un gioco: metterà due sassolini in una borsa, uno bianco e uno nero. Se la ragazza estrae quello bianco, resta libera e il debito viene cancellato. Se estrae quello nero, deve sposare l’usuraio ma il debito viene comunque cancellato.
L’usuraio però bara: mette di nascosto due sassolini neri nella borsa.
La ragazza se ne accorge. Cosa fa? Il pensiero verticale analizzerebbe tre opzioni: rifiutarsi di giocare (il padre va in prigione), denunciare l’imbroglio (rischiando la vendetta dell’usuraio), o estrarre un sassolino nero accettando il matrimonio.
La ragazza però sceglie la quarta via: estrae un sassolino ma, “per sbaglio”, lo lascia cadere tra gli altri sassolini del vialetto. Poi dice: “Oh no, che maldestra! Ma possiamo vedere il colore del sassolino rimasto nella borsa – se è nero, quello che ho estratto era bianco!”
Il pensiero verticale si concentrava su “quale sassolino estrarre”. Il pensiero laterale ha guardato al sassolino bianco che mancava e ha trovato un modo per farlo esistere.
2. Non guardare solo i problemi, parti dal risultato
Invece di fissarsi sul problema, il pensiero laterale parte dalla fine: che risultato vuoi ottenere? Poi lavora a ritroso, passo dopo passo, fino al punto di partenza. È come pianificare un viaggio partendo dalla destinazione anziché dal punto di partenza.
Questo approccio non è una novità assoluta – lo ritroviamo in diverse metodologie. Nella Facilitazione Maieutica, avvalendosi di tecniche come il reverse thinking, si parte dalla soluzione ideale per poi ricostruire il percorso. Il TRIZ (Teoria della Risoluzione Inventiva dei Problemi) usa lo stesso principio: identifica il risultato finale ideale e poi cerca i modi per raggiungerlo, spesso contraddicendo i vincoli apparenti.
Anche tecniche come i Five Whys (o Nine Whys) funzionano al contrario: invece di chiedersi “come risolvo questo problema?”, si chiede “perché questo problema esiste?” risalendo alle cause profonde. Il Critical Path Method, che ben si adatta a un percorso di Facilitazione, parte dall’obiettivo finale e identifica quali sono i passaggi davvero critici per raggiungerlo, eliminando tutto il rumore di contorno.
Ma de Bono va oltre: non si tratta solo di pianificare meglio, ma di cambiare completamente prospettiva sul problema stesso.
3. Fai un po’ di “PO”
De Bono inventa la parola “PO” (provocative operation) come segnale linguistico che indica un’idea non da giudicare subito, ma da usare come punto di partenza per fare una serie di esplorazioni. Non deve essere realistica né applicabile nell’immediato: serve a spostare l’attenzione, rompere schemi e stimolare nuove connessioni. Serve per dare spazio a idee che sembrano assurde, ma che proprio per questo aiutano a vedere le cose in modo diverso.
Pensiamo alla ristorazione. Se dico: “PO: in un ristorante i clienti dovrebbero cucinare da soli”, a prima vista sembra un’idea priva di senso. Ma questa provocazione apre possibilità: esperienze culinarie interattive, corsi di cucina dal vivo, ristoranti-laboratorio dove impari e poi assaggi, format che uniscono convivialità e formazione. Non è l’idea in sé a contare, ma ciò che scatena.
PO e Pensiero laterale nel retail, nel turismo, nella moda
Pensiamo ad altri esempi di PO.
- PO in un negozio di abbigliamento: i clienti dovrebbero uscire senza aver comprato nulla. Provocazione? Sì. Ma ti porta a immaginare esperienze dove il valore non è nell’acquisto, bensì nella prova, nel consiglio di stile, nell’interazione con la community. Potresti pensare a spazi ibridi, showroom o club esclusivi.
- PO per un tour operator: dovrebbe vendere viaggi senza destinazione.
Assurdo? Forse, ma apre al concetto di “viaggio a sorpresa”, formule già sperimentate con successo, oppure pacchetti basati non sul luogo ma sull’esperienza: relax, avventura, incontro con le comunità locali. Per altro ammetto che da viaggiatrice questa cosa mi incuriosisce molto e vorrei prima o poi provarla. - PO nella moda: una collezione dovrebbe essere… invisibile.
Impossibile? Non del tutto. La provocazione può portare a riflettere su capi minimalisti, tessuti trasparenti, moda digitale o virtuale, outfit da mostrare solo in ambienti online, nel metaverso o in realtà aumentata.
PO significa sospendere il giudizio e usare l’assurdo come leva. È un invito a uscire dal pensiero “corretto”, da quel “si è sempre fatto così” che frena l’innovazione. Nel lavoro, come nella vita, serve anche questo: dare cittadinanza a ciò che sembra fuori posto, perché può essere il seme di un cambiamento vero.
4. Riformula la domanda
Einstein diceva che se avesse avuto un’ora per risolvere un problema, avrebbe speso i primi 55 minuti a definirlo bene, perché una volta definito, la soluzione sarebbe stata facile. Spesso la soluzione non arriva perché stiamo facendo la domanda sbagliata.
Questo principio è alla base della Facilitazione Maieutica, che affonda le radici nel metodo socratico. Come spiega Fabrizio Faraco nel suo lavoro sulla facilitazione, riprendendo gli insegnamenti di Socrate, Platone e Aristotele: “Diventa chiave porre la domanda giusta, ovvero quella che genera la motivazione negli individui a costruire la propria risposta”.
Il facilitatore maieutico, come la levatrice socratica, non possiede la verità ma sa come farla emergere. Un buon facilitatore “rende evidente che sa cosa chiedere e come chiederlo, ma è altrettanto evidente che non conosce la risposta e che non esprime nessuna opinione”. Il suo ruolo è far emergere la risposta che già esiste nella stanza, spesso stimolando e sostenendo anche il silenzio, ovvero quello spazio mentale necessario perché le idee prendano forma.
De Bono, in un certo senso, sistematizza quello che Socrate faceva intuitivamente: trasformare le affermazioni in domande per aprire nuove possibilità di pensiero.
Perché è così difficile uscire dai nostri schemi?
“Molti degli errori nel pensiero sono inadeguatezze della percezione piuttosto che errori di logica”, osserva de Bono. Il problema non è che ragioniamo male, è che partiamo da percezioni sbagliate.
Il nostro cervello, per risparmiare energia, crea delle “strade mentali” che diventano sempre più profonde con l’uso. È come un sentiero in montagna: più viene percorso, più diventa marcato e facile da seguire. Ma anche più difficile da abbandonare. Il nostro cervello tende a scegliere la via più economica: si affida a percorsi di pensiero già consolidati, che con l’uso diventano sempre più automatici. È il Sistema 1 che ci descrive Kahneman in Pensieri Lenti e Veloci che prende il sopravvento: rapido, intuitivo e poco dispendioso. Ma proprio per questo ci vincola a schemi difficili da abbandonare.
Questa è la “trappola dell’idea dominante” che de Bono descrive: quando esiste una teoria forte su un argomento, tutti i ragionamenti successivi partono da quella teoria. Anche ottimi scienziati come Pasteur hanno dovuto lottare contro questo meccanismo: i suoi studi sulla vaccinazione furono inizialmente rifiutati non per mancanza di prove, ma perché contraddicevano le idee dominanti dell’epoca.
Di questo tema si occupa magistralmente anche Gianrico Carofiglio in “Elogio dell’Ignoranza e dell’Errore”, che abbiamo già trattato in un altro articolo. Carofiglio ci ricorda come spesso sia proprio la paura di sbagliare a generare gli errori più gravi.
Prendiamo Barry Marshall e Robin Warren: negli anni ’80 scoprirono che la maggior parte delle ulcere gastriche erano causate dal batterio Helicobacter Pylori, non dallo stress o dal cibo piccante come si credeva da decenni. La comunità medica li derise: come poteva un batterio sopravvivere nell’ambiente acido dello stomaco? L’idea dominante era così forte che Marshall dovette infettarsi deliberatamente con il batterio e poi guarire con antibiotici per dimostrare la sua teoria. Ci vollero anni prima che la scoperta fosse accettata, ma alla fine valse loro il Nobel per la Medicina nel 2005.
Ecco il paradosso: più diventiamo “esperti”, più rischiamo di diventare ciechi alle soluzioni che contraddicono la nostra expertise.
“Il bisogno di avere ragione ogni volta è il maggior ostacolo alle nuove idee”, ci ricorda de Bono. La paura di sbagliare ci tiene incollati a quello che sappiamo già.
Nel Marketing: quando usare il Pensiero Laterale vs quello Verticale
Nel mio lavoro di Consulente Marketing e Facilitatrice per Franchising e attività Multisede, vedo questa dinamica ogni giorno. C’è un momento per il pensiero laterale e un momento per quello verticale.
Prima il pensiero laterale, poi quello verticale.
Nella fase di ideazione di una strategia, serve pensiero laterale: quale approccio nessuno ha mai provato? Come possiamo sorprendere il nostro target invece di seguire quello che fanno tutti i competitor?
Poi, una volta trovata l’idea, serve pensiero verticale per l’esecuzione: come organizziamo i contenuti? Quali sono i passaggi logici per implementare la strategia? Che budget serve?
Vi racconto un episodio che mi ha insegnato molto. Qualche mese fa, durante una presentazione per un cliente importante, mi sono accorta che nelle slide c’erano nomi e loghi sbagliati. Un errore clamoroso di cui mi sono accorta solo aprendo il file. La mia prima reazione è stata cercare una scusa tecnica. Poi ho respirato e ho applicato il pensiero laterale: invece di nascondere l’errore, l’ho ammesso. “Ci sono degli errori che vorrei correggere. Avete dieci minuti per un caffè mentre sistemo?”
Sapete cosa è successo? Il cliente ha sorriso: “Finalmente qualcuno che non cerca di vendermela come una strategia voluta.” E da lì è nata una delle conversazioni più autentiche e produttive che abbia mai avuto.
L’errore era diventato una risorsa. Ma solo perché ho smesso di seguire lo schema mentale “gli errori vanno nascosti” e l’ho fatto attivando un pensiero laterale importante: ammettere gli errori non sarà una tragedia, come mi hanno insegnato – ahinoi – durante le scuole.
La Facilitazione come attivatore del Pensiero Laterale
Chi lavora con me sa che spesso dico: “Mi informo e ti faccio sapere”. Non è pigrizia, per me, è strategia. Ho una rete di professionisti con cui mi confronto perché so che le idee migliori nascono dall’incrocio di competenze diverse.
La facilitazione vera non è fare brainstorming dove tutti dicono la prima cosa che gli passa per la testa. È creare le condizioni perché emergano idee che da soli non avremmo mai avuto.
De Bono ha sviluppato la tecnica dei “Sei Cappelli per Pensare”: sei punti di vista diversi (fatti, emozioni, criticità, ottimismo, creatività, controllo) che si applicano allo stesso problema. Non è solo un esercizio, anzi, è un modo per forzare il cervello a uscire dalla sua modalità preferita di pensiero.
Quando facilito un workshop per aiutare un team a trovare una soluzione ignota, il mio ruolo non è avere tutte le risposte. È fare le domande giuste per far emergere risposte che il gruppo già aveva, ma non riusciva a vedere.
Quando affianco un’azienda come Consulente o come Temporary Marketing Manager, il rischio di cadere negli schemi usuali, perché riportati dal board o emersi dall’analisi, non deve addombrare il mio percorso di ricerca della strategia di marketing e comunicazione più corretta, perché altrimenti non darei valore al progetto che sto seguendo (e risultati, ovviamente).
Quando mi occupo di formazione, sia che la eroghi di persona che strutturi un’Academy per aziende, cerco sempre di non dare per scontata l’aula, il programma, lo schema che talvolta mi viene proposto. Per questo metto insieme Facilitazione, tecniche di public speaking, improvvisazione teatrale e tutti gli studi che ho svolto in questi vent’anni di esperienza: pensare che qualcuno esca da un’aula con la sensazione che ho seguito un noioso percorso verticale per me è estremamente frustrante. Sapere che ho unito il pensiero laterale alla costruzione di un sistema di erogazione dei contenuti verticale, beh, è la mia vera sfida.
Il problema della tecnologia che “addormenta” il pensiero
“Potrebbe essere necessario risolvere i problemi non rimuovendo la causa ma progettando la strada da seguire anche se la causa rimane al suo posto”, scrive de Bono. Questa citazione mi fa pensare al nostro rapporto con la tecnologia.
Gli algoritmi dei social media, Netflix, Spotify ci propongono sempre contenuti “simili a quelli che ti sono piaciuti”. È comodo, ma è l’esatto opposto del pensiero laterale. Ci tiene dentro bolle di conferma invece di esporci alla diversità che genera nuove idee.
Quando è stata l’ultima volta che avete avuto un’idea sotto la doccia? O mentre camminavate senza podcast nelle orecchie? Il pensiero laterale ha bisogno di spazio mentale, di noia creativa, di input inaspettati.
Leggere libri come quello di de Bono è un atto di resistenza contro l’algoritmo. È scegliere di esporsi a idee che non avremmo mai cercato attivamente.
Come iniziare (senza aspettare l’ispirazione)
Il pensiero laterale non è un talento innato – è un’abilità che si può allenare. Ecco tre esercizi che potete provare oggi stesso:
- La tecnica del “E se…”
Di fronte a un problema, fate una lista di 20 domande che iniziano con “E se…”. Le prime 5 saranno ovvie, le successive 10 interessanti, le ultime 5 potenzialmente rivoluzionarie. - L’inversione
Invece di chiedervi “Come posso risolvere questo problema?”, chiedetevi “Come potrei peggiorare questo problema?”. Spesso, invertendo le soluzioni peggiori, si trovano quelle migliori. Qui ammetto che ci sono tecniche di Facilitazione meravigliose da applicare. - La provocazione casuale
Aprite un dizionario a caso, puntate il dito su una parola. Ora collegatela al vostro problema. Sembra assurdo? Perfetto, è proprio il punto.
La prossima volta che vi sentite bloccati: cosa fare?
Il pensiero laterale non è magia, è metodologia. È la consapevolezza che le soluzioni migliori raramente arrivano percorrendo sempre la stessa strada.
“Il pensiero laterale è la disponibilità a cambiare intenzionalmente modello all’interno di un sistema basato su modelli”, dice de Bono. In parole semplici: quando gli schemi non funzionano più, abbiamo il coraggio di cambiarli.
La prossima volta che vi sentite bloccati in un problema – professionale, personale, creativo – ricordatevi della ragazza dell’usuraio. Non si è concentrata sul sassolino che doveva estrarre. Ha guardato il sassolino bianco che mancava.
E ha vinto. Poi, se volete, provate a scrivere – ma mi raccomando, in sicurezza – un nuovo percorso rispetto a quello che fate usualmente. E se non siete gente nata per il trekking, fatelo anche con un semplice percorso in città, che vi faccia uscire da uno schema precostituito. Non è una cosa banale da fare, forza la vostra area di comfort e vi fa uscire rispetto alla strada a cui siete sempre abituati. E se lo fate mentre vi state arrovellando per trovare una soluzione a un problema annoso, beh, potreste stupirvi.
E voi, qual è stata la vostra ultima idea “laterale”? Condividete nei commenti, che chissà, potrebbe ispirare qualcun altro a uscire dalla propria comfort zone.
Se il vostro team si trova bloccato negli stessi schemi di sempre e avete bisogno di sbloccare la creatività aziendale, organizzo workshop di Facilitazione in cui integro le tecniche di sviluppo del pensiero laterale specificamente progettati per aziende e team ibridi. Attraverso la Facilitazione Maieutica e le tecniche di de Bono, aiuto i gruppi a trovare soluzioni innovative che da soli non riuscirebbero a vedere.
FAQ – Pensiero Laterale per Aziende
Ok, ok, ho scritto tanto sul pensiero laterale e ci ho messo anche alcuni spunti, sia sulla Facilitazione che sulla Formazione e il Marketing. D’altro canto, mi rendo conto che alla fine di un articolo simile, qualche info pratica aiuta. Ecco dunque le risposte alle domande che mi pongono più spesso.
Cos’è il pensiero laterale e come funziona?
Il pensiero laterale è un metodo sviluppato da Edward de Bono per trovare soluzioni creative uscendo dai percorsi logici tradizionali. Funziona attraverso quattro tecniche principali:
- identificare i presupposti nascosti
- partire dal risultato desiderato
- utilizzare provocazioni creative (“Po”)
- riformulare le domande.
A differenza del pensiero verticale (logico-sequenziale), quello laterale esplora strade apparentemente meno probabili per trovare soluzioni innovative.
Qual è la differenza tra pensiero laterale e brainstorming?
Il brainstorming si concentra sulla generazione di molte idee senza struttura, mentre il pensiero laterale usa tecniche specifiche per cambiare prospettiva sul problema. In realtà, attraverso le tecniche di Facilitazione Maieutica, le due tecniche sono integrabili. Il pensiero laterale non sostituisce la logica ma la precede: prima si creano nuove possibilità, poi si organizzano con metodo verticale. Inoltre, la facilitazione maieutica, avvalendosi delle microstrutture e delle tecniche come il reverse thinking e il TRIZ può integrare il pensiero laterale per risultati più efficaci.
Quando dovrei usare il pensiero laterale nel mio business?
Utilizza il pensiero laterale nella fase di ideazione strategica: quando i competitor fanno tutti la stessa cosa, quando le soluzioni tradizionali non funzionano più, quando devi innovare prodotti o servizi. È particolarmente utile per franchising e attività multisede che devono differenziarsi nel mercato, ma anche per piccole e medie imprese che stanno affrontando cambiamenti importanti, come quelli della carenza di operatori o di confronto con nuove tecnologie. Dopo aver trovato l’idea innovativa, passa al pensiero verticale per l’implementazione pratica.
Come posso sviluppare il pensiero laterale nel mio team?
Il pensiero laterale si può allenare attraverso workshop specifici con la facilitazione maieutica e il LEGO® SERIOUS PLAY®, oppure con l’Improvvisazione Teatrale per le aziende.
Tecniche efficaci includono: la provocazione casuale, l’inversione dei problemi, la tecnica dei “Sei Cappelli per Pensare” di de Bono, e la riformulazione sistematica delle domande. Un facilitatore esperto guida il processo facendo emergere soluzioni che il team già possiede ma non riesce a vedere da solo.
Il pensiero laterale funziona davvero o è solo teoria?
Il pensiero laterale ha prodotto risultati concreti nella storia: dalla scoperta dei raggi X di Röntgen (per caso mentre studiava altro) alla cura dell’Helicobacter pylori di Barry Marshall (contraddicendo 50 anni di medicina che attribuiva le ulcere allo stress). Nel business, aziende come 3M e Google lo usano sistematicamente per l’innovazione. La chiave è alternare pensiero laterale (creazione) e verticale (esecuzione) nei momenti giusti.
Posso applicare il pensiero laterale ai problemi quotidiani?
Assolutamente sì. Il pensiero laterale funziona su problemi piccoli e grandi: da come ottimizzare un processo aziendale a come gestire conflitti nel team. L’importante è cambiare prospettiva: invece di “come risolvo questo problema?” chiedi “che risultato voglio ottenere?” e “cosa sto dando per scontato?”. Anche creare percorsi fisici nuovi (in montagna o in città) può stimolare il pensiero laterale per problemi professionali.
Quali libri consigli per approfondire il pensiero laterale?
Il libro fondamentale è “Il pensiero laterale” (1967) di Edward de Bono, che introduce il concetto e le tecniche base. Utili anche “Sei cappelli per pensare” dello stesso autore e “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” di Gianrico Carofiglio per comprendere come gli errori possano diventare risorse creative. Per la facilitazione, “La Facilitazione Maieutica” di Fabrizio Faraco e “Facilitare la Svolta: teoria e pratica della facilitazione trasformativa” di Adam Kahane offrono strumenti pratici. “Pensieri lenti e veloci” di Kahneman e un must have e aiuta a comprendere i meccanismi cognitivi che il pensiero laterale deve superare.

L’arte di sbagliare bene (e di ammetterlo)
“Il rischio della stupidità riguarda tutti […] è un’attitudine […] e una sua fondamentale caratteristica risiede nella tendenza a mettere etichette e ricorrere a schemi, a formulare precipitose quanto categoriche semplificazioni”. Così, più o meno, potete leggere agli inizi di “Elogio dell’Ignoranza e dell’Errore” di Gianrico Carofiglio.
Mentre cercavo un modo per scrivere di questa importante – per me – lettura, confrontandomi un po’ con l’AI, mi sono sentita suggerire: “perché non racconti di un tuo errore?”… Momento di panico.
Etichetta immediata: “Gli errori sono da nascondere“. Schema automatico: “Se ammetto di sbagliare, perdo credibilità“. Semplificazione categorica: “I professionisti non sbagliano”.
Carofiglio mi aveva appena colto in flagrante stupidità. E l’ironia era servita su un piatto d’argento.
Piccola nota: Carofiglio è stato un magistrato, scrive romanzi, saggi, racconti. Questo libro è uscito pochi anni fa e forse non è uno dei suoi testi più famosi, ma a mio avviso andrebbe fatto leggere a scuola, ecco. Si legge facilmente: sono appena 84 pagine, ma sono dense di significato. Ho provato a farci una riflessione tutta mia. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate.
Quando Carofiglio ti suona la sveglia
Ho letto, riletto e amato “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” di Gianrico Carofiglio, nato dalla sua grande capacità di analisi della realtà e del contesto e dalla sua storia personale, che gli ha permesso di rendersi conto, solo poi, che gli errori sono stati un grande dono per la sua vita. Se c’è una cosa che questo libro fa bene è suonarti la sveglia sui tuoi automatismi. Non con schiaffi morali, ma con quella gentilezza chirurgica tipica di chi ha passato anni nei tribunali a osservare la natura umana.
Ma attenzione: Carofiglio non è qui per venderci l’ennesima ricetta motivazionale. Anzi, ci mette in guardia proprio da questo. Come scrive: “Viviamo in un’epoca in cui la retorica tossica del pensiero positivo e del fallire meglio sembra onnipresente. Siamo costantemente bombardati di messaggi sulla necessità di abbracciare tutti i nostri errori e inserirli in una narrazione mitologica e banalmente ottimistica della vita e dell’esperienza.”
Ecco, finalmente qualcuno che lo dice. Non tutti gli errori sono lezioni travestite. A volte un errore è semplicemente… un errore.
Eppure eccomi qui, consulente di marketing che forma altri professionisti, con la paura istintiva di ammettere che sì, sbaglio ancora. Regolarmente. E la cosa che mi frega sempre è il mio giudizio sull’errore.
L’errore che non ti aspetti
Allora ve ne racconto uno, di errore. Qualche mese fa stavo preparando una presentazione per un cliente importante. Franchising, strategie, numeri, tutto perfetto. O almeno così credevo.
Arrivo in sala, apro Canva e… nel riprendere il modello delle slide, avevo dimenticato di togliere delle cose di un progetto precedente. C’erano nomi sbagliati e anche qualche logo sbagliato. Di fatto non avevo ricontrollato le slide e l’ultimo salvataggio, boh, forse mi ero dimenticata di farlo, o non so, perché quando succedono queste cose ti appelli a qualsiasi capro espiatorio, no? Cioè, il primo pensiero è che non sia colpa mia, ecco. Non succede anche a voi?
La mia prima reazione? Cercare disperatamente una scusa. Un problema tecnico, un file corrotto, qualsiasi cosa pur di non dire “ho sbagliato io”.
Poi ho respirato e ho fatto una cosa che Carofiglio avrebbe approvato: ho ammesso l’errore. Non con drammi o giustificazioni, ma con onestà. “Ci sono degli errori nelle slide che vorrei correggere. Avete dieci minuti per un caffè mentre sistemo?”
Quello che è successo dopo
Sapete cosa è successo? Il cliente ha sorriso. “Finalmente qualcuno che non cerca di vendermela come una strategia voluta.” E da lì è nata una delle conversazioni più autentiche e produttive che abbia mai avuto.
L’errore aveva fatto quello che nessuna presentazione perfetta avrebbe mai potuto fare: aveva abbattuto le barriere, creato connessione umana, aperto spazio al dialogo vero.
Ma non voglio cadere nella trappola che Carofiglio stesso denuncia: non sto dicendo che tutti gli errori sono benedizioni travestite. Come lui scrive: “L’accettazione degli errori e dei fallimenti non contribuisce al progresso perché tutti gli errori e i fallimenti sono utili o contengono lezioni da impartire. Vederli come parte integrante della nostra umanità, anche quando non portano da nessuna parte, ci permette però di muoverci con più scioltezza, meno ansia, senza il peso della perfezione che spesso ci imponiamo.”
Ecco il punto: non è che sbagliare sia sempre utile. È che accettare di essere imperfetti ci fa respirare meglio (anche se prima dovremmo liberarci di quell’effetto apnea che ci viene a pensare di dover ammettere di aver sbagliato).
Il paradosso della competenza
Chi lavora con me sa che spesso una frase che dico è: “mi informo e ti faccio sapere”. La fortuna (o magari una capacità relazionale che potrei attribuirmi) è che ho una grande rete di professionisti con cui ci misuriamo e ci confrontiamo, consapevoli (la gran parte) che non si nasce mai “imparati”. Ed ecco che allora, talvolta, scatta un altro “piccolo” errore: sottovaluto – o sopravvaluto – il tempo di risposta degli altri. Facciamo un esempio: problema X, su cui ho una mezza idea di sapere la soluzione, ma non voglio fare come il fuffa guru che sa tutto e preferisco approfondire. So che il professionista K potrebbe avere la soluzione e dico al cliente che mi prendo un paio di giorni (?) per rispondere. Il fatto è che il cliente vorrebbe fare tutto subito e non mi lascia il tempo di sentire questa persona, parlarci e attendere i suoi tempi. Quante volte mi sono trovata a gestire una situazione simile! Qui l’errore – mio – è di valutazione del tempo altrui, mentre – del cliente – l’impazienza, grande cattiva consigliera di questi tempi.
Viviamo in una cultura che ha trasformato l’errore in una colpa morale. Sui social, nel lavoro, nelle relazioni: devi sempre sapere tutto, essere sempre al top, non mostrare mai incertezza. E devi sapere tutto subito, immediatamente, perché non c’è tempo, il che incide ancora di più nella possibilità di errare.
Questo ci sta uccidendo, ci sta togliendo quella sana capacità creativa che un errore sviluppa, specie se riconosciuto: l’arte di trovare soluzioni e migliorarci, evitando di reiterare quell’errore. Carofiglio la chiama “la trappola della conoscenza” e la descrive così: “Le persone, a causa delle competenze e delle abilità acquisite, tendono a ripetere comportamenti già collaudati senza adattarsi a nuove circostanze; tendono a formulare sempre le stesse diagnosi; tendono a commettere errori (spesso: gli stessi errori) senza essere capaci di ammetterli, senza essere capaci di autocorreggersi. La trappola della conoscenza genera una visione miope e autoreferenziale, un pensiero rigido e dunque incapace di adattarsi alla complessità dell’esperienza.”
Ecco il paradosso: più diventiamo “esperti”, più rischiamo di diventare ciechi. Nel mio lavoro di facilitatrice, formatrice e marketing manager pro tempore vedo questo ogni giorno. I consulenti più bravi non sono quelli che sanno tutto, ma quelli che sanno dire “non lo so, ma lo scopriamo insieme”. I leader più efficaci non sono quelli che non sbagliano mai, ma quelli che trasformano gli errori in opportunità di apprendimento per tutto il team.
L’ignoranza come superpotere
Ma qui Carofiglio ci porta oltre la semplice accettazione. Ci ricorda che spesso è proprio la paura di sbagliare a generare gli errori peggiori. “Dunque, taluni (molti, in realtà) cercano di evitare del tutto gli errori. Ed è proprio questo sforzo di evitare ogni errore a ogni costo che genera più facilmente fallimenti gravi, a volte disastrosi e irreversibili.”
Mi viene in mente quando ero piccina e avevo una Yashica FXD mentre tutti i miei amici usavano le macchinette automatiche. Loro facevano una foto per volta, io ne facevo decine della stessa scena. Carofiglio direbbe che avevo capito qualcosa di importante: “Si pensi ai grandi fotografi: per tirare fuori una buona foto ne fanno centinaia e centinaia che poi scarteranno.” (Non che io sia una grande fotografa, eh, anche se l’ho sognato).
Non si tratta di sprecare pellicola (o pixel, oggi). Si tratta di accettare che la bellezza nasce dalla sperimentazione, non dalla paura di sbagliare. Quando accetti di non sapere, apri spazio alla curiosità. Quando ammetti di aver sbagliato, inviti gli altri a fare lo stesso. Quando mostri vulnerabilità, crei connessione.
È quello che cerco di fare in questo blog: partire dalle mie riflessioni, dai miei dubbi, dai miei errori, per aprire conversazioni che possano alleggerire la vita a chi legge. Non perché ho le risposte, ma proprio perché non le ho.
Il coraggio di essere imperfetti
Allora eccomi qui, a quarant’anni suonati (ops, ho detto l’età e si sta pure avvicinando il mio genetliaco!), ancora a imparare l’arte di sbagliare bene. Ancora a scoprire che dietro ogni errore ammesso c’è una possibilità di crescita. Dietro ogni “non lo so” c’è una porta che si apre.
Carofiglio ci ricorda che il vero coraggio non è non avere paura di sbagliare. È avere il coraggio di essere imperfetti in un mondo che ci chiede di essere sempre al top.
E sapete una cosa? È liberatorio. Come quel sospiro che tiri quando finalmente puoi toglierti le scarpe strette dopo una giornata lunga, magari una di quelle in cui hai fatto 700 metri di dislivello in montagna e non vedevi l’ora di raggiungere la cima.
L’invito a sbagliare, sbagliare meglio
Quindi ecco il mio invito, ispirato dal libro di Carofiglio: proviamo a sbagliare meglio. Non nel senso di sbagliare di più, ma di farlo con consapevolezza, accettazione, e perché no, anche con un sorriso.
Proviamo a dire “non lo so” più spesso. A ammettere quando abbiamo torto. A trasformare gli errori in storie che valgono la pena raccontare. Non è facile. Il nostro cervello è programmato per proteggerci dalla vergogna. Ma forse è proprio lì, in quella zona di discomfort, che inizia la vera crescita. Come dice Carofiglio, l’ignoranza e l’errore non sono nemici da combattere. Sono compagni di viaggio da abbracciare.
E io, per cominciare, vi ho appena raccontato quello delle slide sbagliate.
A voi tocca.
Bibliografia: Gianrico Carofiglio, Elogio dell’ignoranza e dell’errore, Einaudi, 2024

Basta team building! Emergi!
Dove finisce il team building, comincia l’innovazione (vera!)
Quante volte ci siamo illusi che un team potesse nascere da un’attività di team building ben organizzata? Un pomeriggio fuori sede, qualche gioco di squadra, magari un risultato immediato… Eppure, pochi giorni dopo, tutto tornava come prima.
La verità è semplice: i team non si costruiscono. I team emergono. Emergono quando le persone smettono di recitare un ruolo e iniziano a costruire insieme significati, visioni, percorsi.
💡 È qui che entra in gioco il lavoro sulle metafore tridimensionali, il pensiero con le mani, l’ascolto profondo. Non è solo questione di tecniche: è questione di creare spazi di intelligenza condivisa.
Perché il team building tradizionale non basta più
Il team building tradizionale parte da un’idea affascinante: creare coesione attraverso esperienze condivise. Ma troppo spesso si limita a momenti isolati, incapaci di toccare i meccanismi profondi che regolano la collaborazione. Scatta il momento creativo: si va alla ricerca dell’idea più nuova e avvincente, mixando gioco, teatro, tecniche di facilitazione, role play, il tutto senza un vero scopo. Abbiamo a disposizione gli ingredienti più belli della nostra azienda: le persone. Ma la ricetta per farli lavorare insieme? Spesso è sconosciuta o lasciata al caso.
Un momento di team building non può essere creato su una giornata o un weekend di divertimento: le problematiche del gruppo di lavoro si congelano, ma già dal lunedì successivo si sciolgono i ghiacciai e si alzano le maree. No, non funziona così. Abbiamo abusato e utilizzato troppo a sfavore del vero valore del team di un’azienda il termine team building.
Come scrivono Lipmanowicz e McCandless, “la chimera che le buone pratiche importate da altri contesti possano funzionare ovunque è troppo attraente per resistere alla tentazione di crederci”.
Ogni team è unico. Ogni sfida è diversa. Non si tratta di replicare formule. Si tratta di far emergere risposte autentiche.
Qualche tempo fa ho parlato con un imprenditore sconsolato: la sua azienda organizza ogni anno un retreat (e già il nome la dice lunga, ma lasciamolo lì). Ebbene, durante l’ultimo weekend hanno affittato una bellissima location, con stanze comode e spazi condivisi funzionali. Hanno lasciato spazio allo svago. Hanno provato a fare un role play. Tutto sembrava carino e condiviso. Tutto era stato creato per amalgamare squadre diverse su sedi diverse in Italia e nel mondo. Risultato? Quest’anno non si farà più. Il sondaggio (anonimo) di fine anno ha raccolto così tanti dissensi e voti sfavorevoli, così tante polemiche su location, obiettivi e attività svolte che l’imprenditore ha deciso, con il capo del personale, che questi soldi era bene investirli altrove. Come dargli torto? Come fargli cambiare idea per creare un momento condiviso ma allo stesso tempo funzionale?
L’emergence: quando i team nascono davvero
Henry Mintzberg lo ha spiegato bene: nelle organizzazioni complesse e nei mercati instabili, la strategia non si pianifica, emerge.
Come fa notare Fabrizio Faraco nel suo “La Facilitazione Maieutica” (La Traccia Buona) Emergence è una parola inglese che non ben si presta alla traduzione italiana. “La sfumatura di significato inglese è più focalizzata sull’evento: emergence è un sostantivo che risale dalla radice latina emergere, che significa portare alla luce, ed è entrato nell’inglese nel XVII secolo: quando qualcosa viene alla luce dove prima c’era l’oscurità (o il nulla) avviene un’emergence. Il termine” continua Faraco “fu poi utilizzato in senso scientifico da George Henry Lewes in ‘Problems of Life and Mind’ del 1875, dove traccia la distinzione fra effetti risultanti ed emergenti: sono risultanti se possono essere calcolati a priori, sono invece emergenti quando sono qualitativamente nuovi rispetto alle cause da cui scaturiscono”.
Allo stesso modo, un team efficace non si costruisce a tavolino. Si aiuta a emergere attraverso ascolto, connessioni, esperienze condivise che rivelano il potenziale nascosto.
Favorire l’emergence è diverso da “guidare”: significa creare le condizioni perché le persone possano costruire insieme, adattandosi e innovando. Il ruolo del Facilitatore Invisibile è la chiave di svolta per workshop e incontri di team proficui, pratici e soddisfacenti: capace di chiedere e sapere cosa chiedere, ma soprattutto di non avere le risposte per essere un buon ascoltatore (come consigliò Dale Carnegie nel 1936 in ‘How to find friends and influence people’) è “capace di aiutare un gruppo a raggiungere i suoi obiettivi […]” come “architetto di uno spazio sicuro in cui le idee possono fiorire, i conflitti possono essere risolti e si può raggiungere il pieno impegno” (cit. Jack Reimon, p. 44 sempre su La Facilitazione Maieutica di Fabrizio Faraco).
Caro amico imprenditore, non me ne volere se ti ho chiesto chi avesse orchestrato il tuo team building: quando mi hai risposto che è stato l’ufficio del personale, ti avrei abbracciato forte. Purtroppo, se davvero volevi un retreat capace di creare e costruire un team, ma soprattutto di dare il la per un lavoro condiviso, anche il tuo ufficio del personale andava inserito nel processo e, quindi, facilitato. In un momento in cui tutta l’azienda ha l’arduo compito di creare un collegamento solido, non ci possono essere membri interni che guidano un processo come quello di un role play. E sì, anche tu, amico imprenditore, avresti potuto partecipare. Far emergere significa anche questo.
Pensare con le mani: il sapere nascosto nei gesti
Quando si cercano nuove soluzioni, si vuole generare idee, si ha bisogno di risolvere problemi, spesso si ricorre a una serie di riunioni. Si dice che gli italiani amino a tal punto le riunioni da passare più tempo all’interno di meeting che a lavorare davvero. Secondo alcuni studi, tra cui uno di Asana, un altro di Accountemps e diverse interviste che sono state fatte prima e dopo la Pandemia, passiamo dal 20 al 50% del tempo in call e riunioni, di cui stimiamo che oltre il 25% sia sprecato. Non solo, spesso le riunioni non hanno ordini del giorno chiari, è faticoso tenere le fila di un discorso e – ancora peggio – le riunioni si chiudono senza chiari input per svolgere attività concrete.
Il problema sono i lavoratori che parlano troppo o i manager che amano ascoltare la propria voce? Già W. Edwards Deming (ingegnere statunitense che ha segnato il passo del tema della Qualità nella produzione) ci ricorda che “Il lavoratore non è il problema. Il problema è il top-management”. La realtà dei fatti è che, per ritrovare Faraco
“Ci risulta normale attivare il nostro ragionamento usando la lingua. Siamo invece meno abituati a farlo usando le mani: una risorsa importante, dato che il 70-80% delle connessioni neurali sono tra mani e cervello”. La mano è molto più di un semplice strumento esecutivo. Robert Rasmussen, uno dei fondatori della metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®, parla di “hand knowledge”: una conoscenza implicita che si attiva quando costruiamo, manipoliamo, diamo forma fisica ai pensieri.
Il neurologo Wilder Penfield, attraverso la rappresentazione dell’homunculus, ha mostrato che una porzione enorme della nostra corteccia cerebrale è dedicata proprio al controllo fine delle mani.
🤚 Pensare con le mani significa attivare risorse cognitive profonde, spesso inacessibili con il solo linguaggio verbale.
Quando chiediamo a un team di costruire metafore tridimensionali usando mani, materiali, simboli, stiamo attivando intelligenza concreta, pensiero laterale, connessioni emotive.
“Quando si riuniscono un numero di persone desiderose di contribuire all’innovazione, ma che non sanno esattamente come possono contribuire, diventa fondamentale che la conoscenza di ciascun individuo venga sbloccata e condivisa. Il messaggio è questo: per innovare e trasformare imprese e attività è necessario che tutti attivino maggiormente le proprie conoscenze e vadano oltre il primo schema riconosciuto” (Per Kristiansen, Playing seriously with innovation, Medium, 23 giugno 2022)
Non è “giocare”. È pensare meglio.
Perché le metafore tridimensionali cambiano i team
Le metafore costruite con le mani permettono di:
- Visualizzare ciò che non si riesce a esprimere a parole
- Allineare visioni diverse, senza forzare omogeneità
- Attivare emozioni e memoria, rendendo l’apprendimento più profondo
Ogni costruzione diventa un linguaggio comune. Un ponte tra punti di vista diversi. Un terreno condiviso su cui costruire nuove strade.
Si attinge alla conoscenza tacita, ovvero a quel tipo di conoscenza che si è formato nell’esperienza, nel contatto con la vita, il lavoro e le persone, e che si è unito ai valori e ai modelli mentali che abbiamo costruito nel tempo. Usare le metafore tridimensionali e attivare le mani consente dunque di sbloccare il potenziale di ognuno, in uno spazio protetto, dove vi sia una sicurezza psicologica innescata dal grande lavoro del Facilitatore.
Caro amico imprenditore, sì, orchestrando bene gli elementi del tuo team, quel retreat avrebbe potuto diventare davvero un incontro fuori sede dove team, manager o leader si ritirano per lavorare su obiettivi strategici, cultura organizzativa, allineamento di visione, collaborazione, spesso combinando lavoro intenso e momenti di crescita personale o di team. Magari avremmo potuto dargli un nome tipo Emergence Space, ma su quello possiamo anche lasciarti la libertà di espressione :).
LEGO® SERIOUS PLAY® come strumento per far emergere, non per fare team building
Purtroppo da quando ho preso la certificazione come Facilitatrice LEGO® SERIOUS PLAY® con Per Kristiansen, mi è capitato spesso di sentire che questa metodologia viene richiesta per incontri di team building e per – addirittura – le cene di Natale. Ogni volta che sente questa cosa un neurone di Per muore (e non solo i suoi!)… per fortuna che ne ha tantissimi.
Ma non importa che Per Kristiansen e Robert Rasmussen siano oggi i detentori di un Metodo che richiede costante formazione, approfondimento e pratica. Non importa che per ottenere la certificazione servano importanti investimenti e giorni di studio chiusi in una stanza con Per. Non importa che ci siano ancora pochi Facilitatori LEGO® SERIOUS PLAY® nel mondo, nonostante le migliaiai di ore di volo che i fondatori di Trivium International fanno ogni anno per portare questo Metodo ovunque. Cioè, questo importa, sì, ma importa di più che chi parla di questo strumento potentissimo per far emergere, ovvero portare significative soluzioni alla luce, quando lo riduce a un gioco da fare durante una convention o un momento di team building, sta castrando il suo potenziale. Si tratta di un Serious Play e come Facilitatori ne abbiamo tutta la responsabilità.
Come Facilitatori Certificati abbiamo il compito e l’opportunità di avere lo strumento per rispondere all’esigenza di un’azienda, come quella di trovare nuove soluzioni di collaborazione per un team, o di integrare team diversi o – e cito solo alcune possibilità fra le tantissime – generare nuove soluzioni concrete per un problema noto e da mesi irrisolto in riunioni fiume dove parlano i soliti noti e si sentono esclusi i soliti ignoti.
Facilitare un workshop con il Metodo LEGO® SERIOUS PLAY® non è dunque team building, mi dispiace, caro amico imprenditore (e anche caro amico facilitatore).
Cosa succede in un team che smette di “fare team building” e inizia a emergere, anche con il Metodo LEGO® SERIOUS PLAY®?
Quando si facilita davvero l’emergere di un team:
- Prima: silenzi strategici, conflitti latenti, visioni disallineate
- Dopo: ascolto autentico, ownership distribuito, collaborazione naturale
Secondo il progetto Aristotele di Google, la sicurezza psicologica è il fattore chiave dei team performanti. E facilitare l’emergence significa creare proprio questa sicurezza, questo spazio libero di esplorazione.
“Muoversi in una strategia emergente richiede che il focus sia sulle persone e sui risultati, garantendo che le persone prendano decisioni autonome e allineate […]. Per costruire strategie emergenti, è necessario comprendere il contesto, sperimentare, raccogliere dati, adattarsi a collaborare, che è esattamente quello che si realizza in una attività di facilitazione” (afferma il nostro Fabrizio Faraco a pag. 64 del suo libro).
Inoltre, ponendo le domande giuste (“What if?”, “How might we?”) anziché dare risposte precotte, si aiuta il team a costruire senso e direzione in modo autonomo e duraturo. Anche il tema delle domande, negli incontri di Facilitazione, ha il peso specifico giusto.
Quando serve emergere, non costruire
Ci sono situazioni in cui replicare modelli standard di team building è addirittura controproducente:
- Fusioni e acquisizioni: servono spazi per integrare culture diverse, non simulazioni artificiali
- Team di innovazione: servono metodi per stimolare pensiero divergente, non esercizi di allineamento
- Leadership distribuita: serve ownership, non gerarchie camuffate
In tutti questi casi (e non solo!) Facilitare l’emergence è l’unica via per creare team veri, capaci di adattarsi, crescere e innovare insieme. E sì, è possibile, senza ore di riunioni inutili e senza grandi spese per location superlative e cene luculliane.
Vuoi che il tuo team emerga davvero?
Se vuoi innovare davvero, non devi costruire il tuo team come si monta un mobile (a quello ci pensano gli svedesi, ok?). Devi creare le condizioni perché emerga la sua forma migliore. Devi creare le condizioni perché le persone collaborino davvero. devi metterti in gioco (caro imprenditore) talvolta in prima persona, nella stanza o fuori.
Lavorare sul “sapere delle mani”, sulle metafore costruite, sulla facilitazione dell’emergere delle idee è il modo più potente e naturale per farlo.
👉 Contattami se vuoi scoprire come progettare un percorso su misura per aiutare il tuo team a emergere.
Perché il futuro dei team, quello vero, inizia dove finisce il team building.
Individui e Interazioni, Ferrara, 7 maggio 2025
Se vuoi partecipare a un workshop con il Metodo LEGO® SERIOUS PLAY® pratico, c’è ancora qualche posto per una giornata con me e Andrea Romoli durante il Festival Individui e Interazioni, a Ferrara, presso il Consorzio Wunderkammer, il 7 maggio 2025. Il workshop è pensato per team che si chiedono come migliorare i rapporti di collaborazione e potenziare l’efficacia operativa. Se fai parte di:
- Team di prodotto
- Team di design
- Team di sviluppo
e se ti rendi conto che non trovi la strada giusta per rendere il tuo team più unito, efficiente e capace di rispondere alle sfide che chiede il mercato, andremo a sviluppare strumenti concreti per farlo.
Non sempre, infatti, le idee di miglioramento nascono all’interno di team omogenei. Affrontare nuove sfide o risolvere problematiche complesse può richiedere interazione e coinvolgimento di fattori esterni e di conoscenza tacita che non avevamo considerato di esplorare. Il contesto di IEI25 nasce proprio per con lo spirito di sapere “quanto sia complesso far funzionare la collaborazione tra design, sviluppo e organizzazione. Non si tratta solo di processi, metodologie o ruoli ben definiti, ma di interazioni reali tra persone con competenze diverse, obiettivi da allineare e decisioni da prendere insieme.”
Per iscriverti segui il link al Workshop “Product Team 2.0: costruire un team ad alta performance con LEGO® SERIOUS PLAY®” a Ferrara
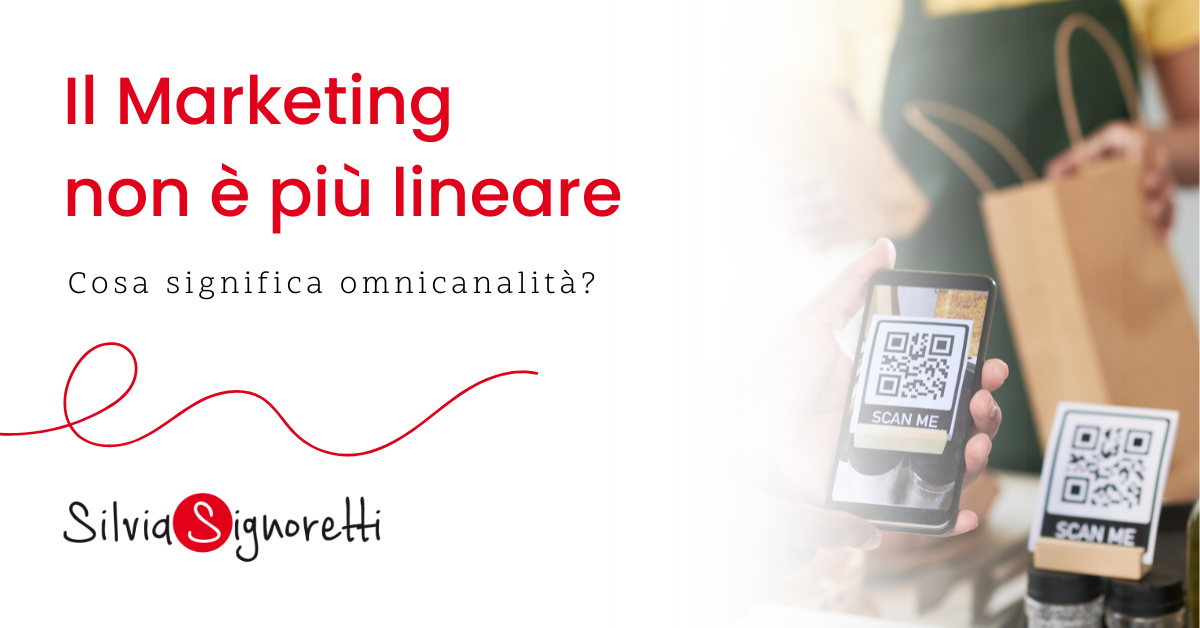
Il Marketing non è più lineare
Nel 2025, il marketing non può più essere monodirezionale. I consumatori si muovono tra TV, social media, negozi fisici, e-commerce, app e assistenti vocali, aspettandosi un’esperienza coerente e fluida ovunque.
Questa strategia si chiama omnicanalità ed è la vera differenza tra un brand che sopravvive e uno che domina il mercato.
Ma cosa significa davvero essere omnicanale? E quali aziende lo stanno facendo nel modo giusto?
Cos’è l’Omnicanalità?
L’omnicanalità è la capacità di un brand di offrire un’esperienza coerente su tutti i canali:
- Online e offline si fondono → Un cliente può iniziare l’acquisto su un sito web, provarlo in negozio e completarlo tramite app.
- I dati migliorano l’esperienza → Un brand raccoglie informazioni da più canali per offrire raccomandazioni personalizzate.
- Ogni touchpoint è connesso → Che sia un post Instagram, una pubblicità in TV o un’email, il messaggio è coerente e rilevante.
Multicanalità VS omnicanalità:
- Multicanale → Il brand è presente su più piattaforme, ma i canali non comunicano tra loro.
- Omnicanale → Tutti i canali sono interconnessi per creare un’unica esperienza fluida.
Tre esempi di Omnicanalità
Quali aziende si stanno muovendo in modo sistematico nell’omincanalità? Non è semplice attivare un processo di rivoluzione omnicanale in azienda. Innanzitutto, l’azienda deve far compenetrare i reparti e reagire agli stimoli in modo univoco; poi, deve interrogarsi sul fatto che non basta un sistema o un gestionale per essere omnichannel, serve una cultura aziendale solida. Il rischio di affrontare un percorso omnicanale senza un piano, affidandosi solo ai tool, è quello di lasciare fuori opportunità e persone.
E mentre si parla diffusamente di questo approccio, solo una bassa percentuale di imprese può dire davvero di essere omnichannel. Vediamo alcuni esempi presi da grandi brand, che se pur abbiano risorse e strumenti sicuramente più forti di altri, possono essere spunto per alcune riflessioni, anche di chi non ha queste capacità strutturali. L’importante, come dicevo, è iniziare ad analizzare e sviluppare la “mentalità”.
1. Nike: dal negozio all’app, senza soluzione di continuità
Nike ha creato un ecosistema perfettamente integrato:
- L’app Nike consiglia i prodotti in base agli acquisti precedenti.
- In negozio, il cliente può scansionare un QR code per vedere la disponibilità di taglie e colori.
- Dopo l’acquisto, riceve notifiche con consigli su come usare il prodotto.
Cosa possiamo imparare da Nike? Usare la tecnologia per collegare l’esperienza online e offline e rendere l’acquisto più intuitivo.
2. Starbucks: la fidelizzazione omnicanale perfetta
- L’app Starbucks permette di ordinare e pagare in anticipo, evitando code.
- I punti fedeltà si accumulano indipendentemente dal canale d’acquisto (app, negozio, drive-thru).
- L’utente riceve offerte personalizzate basate sulle sue preferenze.
Cosa possiamo imparare da Starbucks? Il programma fedeltà deve essere integrato su tutti i canali, premiando ogni interazione con il brand. Non è così scontato. Eppure è quello che chiedono gli utenti/clienti: continuità, nell’esperienza e nei flussi.
Piccola riflessione sui programmi fedeltà nei Franchising: mi sono trovata spesso ad analizzare le opportunità di crescita del sistema di affiliazione rispetto alla fidelizzazione degli utenti: da un lato i clienti vivono il brand e non sentono di essere all’interno di punti vendita differenti, per cui, sia che si trovino in una città che in un’altra, vogliono avere un’esperienza omologa; dall’altro gli affiliati, soprattutto di Franchising storici, si sentono indipendenti e creano frizioni quando si vogliono sviluppare programmi di loyalty, a svantaggio del sistema di Franchising tutto.
3. Sephora: esperienza cliente senza frizioni
- I clienti possono salvare prodotti sull’app e ritrovarli automaticamente in negozio.
- L’AI suggerisce il make-up perfetto in base alla carnagione dell’utente.
- I consulenti in negozio hanno accesso al profilo online del cliente per personalizzare i consigli.
Cosa possiamo imparare da Sephora? Personalizzazione e continuità sono le chiavi per fidelizzare il cliente.
Omnicanalità ed eventi: cosa possono imparare Super Bowl e Sanremo?
Gli eventi di grande impatto possono diventare piattaforme perfette per strategie omnicanale. Possiamo tranquillamente dire che gli eventi che segnano, solitamente, il passo sulla pubblicità e i nuovi trend sono quelli più seguiti dal pubblico. Da un lato, il Super Bowl, in America, dall’altro (almeno fino al 2024) Sanremo, per il nostro Paese. Vediamo come i brand hanno sfruttato questi due eventi e cosa possiamo imparare.
Super Bowl: il modello perfetto
Le aziende che investono nel Super Bowl sono davvero tante. I costi degli spazi pubblicitari, enormi. Ma quello che ha sempre caratterizzato il Super Bowl è la creatività: gli inserzionisti, gli investitori, non solo hanno gli spazi in TV o a bordo campo, ma possono ideare vere e proprie esperienze dentro e fuori gli stadi. Non c’è limite (o ce ne sono pochi). In effetti, scegliere di investire cifre così importanti dovrebbe portare anche a progettare il miglior spot di sempre, per fissare negli spettatori l’idea del marchio, il suo valore e un ricordo indelebile dei suoi prodotti. Fare diversamente sarebbe come decidere di comprare il biglietto del ballo delle debuttanti e andarci con un saio. Un grande investimento richiede dunque il miglior vestito.
Cosa abbiamo visto al Super Bowl 2025?
- Spot TV con teaser pre-evento su TikTok e Instagram.
- Coinvolgimento degli utenti sui social (challenge, meme, commenti live).
- Engagement post-evento con contenuti esclusivi e offerte speciali.
Il grande tema è stato coinvolgere attori e personaggi famosi, la sfida realizzare quasi dei film. I messaggi, a seconda del brand, sono di diversa natura: da quelli più forti a quelli più ironici. Alcuni esempi?
- Dove ha trasformato il suo spot in un movimento sociale sui social media, prolungando la visibilità ben oltre la diretta TV. La bambina che corre sulla scia dello slogan Born To Run ha fatto emozionare tutti. Dove ha collaborato con H.E.R., artista da 6,6 mln di follower, per la realizzazione dello spot;
- Stella Artois ha messo in campo un vero film: quello della ricerca del gemello perduto di David Beckham in America. E chi è il gemello perduto? Niente poco di meno che Matt Damon;
- Ray-Ban continua a spingere i suoi occhiali in collaborazione con Meta giocando sul real time marketing. Non solo ha usato un cast stellare, con Chris Pratt, Christopher Hemsworth e Kris Jenner, ma ha spinto su una delle opere d’arte più discusse degli ultimi mesi, la famosa Banana di Cattelan, 6,2 milioni di dollari di valore. Lo spot appartiene a una serie, che vuole avvicinare quanti più consumatori possibili agli occhiali, anche se non sembra che il prodotto stia ancora avendo il successo atteso;
- Pringles ha sfruttato la notorietà, acuita dai recenti riconoscimenti, di Adam Brody, con uno spot che lo mostra in crisi per mancanza di Pringles a un party. Il tubo si trasforma così in un piffero magico richiama baffi, che vediamo partire da tutto il mondo.
Questi sono solo alcuni, tra cui vi invito a vedere anche GoDaddy, Lay’s e Ritz. Ma lo spot che più ha portato animo alla discussione sulle pubblicità del Super Bowl è certamente quello di Hellmann’s, che ha ingaggiato proprio Billy Crystal e Meg Ryan perché riprendessero i loro ruoli in “Harry ti presento Sally” e rifare, nella stessa location – il Katz’s Delicatessen – la scena cult dell’orgasmo, 35 anni dopo il successo del film. Forse troppo, per della maionese’? Forse loro poco credibili? Tra apprezzamenti e critiche, di fatto lo spot mostra che non c’è limite alla fantasia, nella creazione dello spot più discusso del Super Bowl, che si dimostra non solo utile per il pubblico massmediatico, ma anche per i differenti canali di critica e divulgazione pubblicitaria.
Sanremo: l’occasione mancata?
Sanremo ha il potenziale per diventare un evento omnicanale, ma i brand non lo sfruttano appieno. O meglio, il Sanremo di Amadeus ci aveva abituati a inserimenti pubblicitari creativi e collaborazioni più ampie del solito inserimento televisivo. Non sono mancati certo i palchi esterni e le avventure per raggiungere la nave Costa di turno, così come le automobili che hanno accompagnato i cantanti all’Ariston, ma mi sarei aspettata qualche sforzo in più, come il bell’esercizio di Poltrone e Sofà dello scorso anno di accompagnare gli artigiani della qualità dentro al Festival, in un creativo Divano Sanremo che ha coinvolto tutti e che voleva avvicinare il pubblico da casa, con non pochi meta messaggi.
Quest’anno gli spot sono stati poco creativi, non solo al Festival, ma anche nella messa in onda. A fronte di cifre da capogiro (un minuto nella fascia delle 23.30 è arrivato a costare più di 1 milione di euro, ancora più alta la cifra de 4 spot prima dell’annuncio del vincitore) i brand che hanno acquistato gli spazi avrebbero potuto fare di più: niente spot nuovi, quasi nulla la co-partecipazione al Festival. Alcuni main sponsor non sono stati nemmeno in grado di condividere l’esperienza sui social, riducendo la presenza al canale televisivo. Peccato!
Cosa avrebbero potuto fare gli sponsor?
- Creare attivazioni digitali live per far interagire gli spettatori con lo spettacolo.
- Integrare e-commerce e app per acquisti in tempo reale.
- Sfruttare contenuti dietro le quinte su TikTok e Instagram.
Chi ha fatto qualcosa di interessante (se pur un po’ scontato, considerato il tipo di brand)? Spotify ha promosso la playlist di Sanremo. Certo, poteva creare challenge interattive o sondaggi live per aumentare l’engagement. Forse la cosa più omnichannel che si è vista è stata l’interazione degli utenti TIM con la app per assegnare il premio (che poi è andato a Giorgia). Avere una App è un obiettivo per molte aziende, permettendo di raccogliere dati, interagire, creare un canale diretto di dialogo, ma come rendere gli utenti partecipi e far aprire quella App è il vero tema, che pochi hanno risolto: TIM, grazie ai voti della miglior canzone, ci è riuscita. Chapeau perché mi ha permesso di parlare di omnichannel 😀.
Come applicare l’omnicanalità nel tuo brand?
Sì, lo so, c’è ancora tanta confusione su cosa sia o non sia omnichannel. Ma quali sono i punti di partenza e gli obiettivi che dovreste darvi quando vi avvicinate a questo tema e alle sue opportunità?
🔹 Assicurati che il messaggio sia coerente su tutti i canali.
🔹 Utilizza i dati per personalizzare l’esperienza utente.
🔹 Sfrutta la tecnologia per connettere online e offline.
🔹 Incoraggia l’interazione e il coinvolgimento.
La regola d’oro?
Il cliente non deve mai sentirsi perso o confuso quando passa da un canale all’altro. Tutto deve essere connesso.
L’Omnicanalità è il futuro del Marketing?
I brand che riescono a creare un’esperienza fluida, coerente e personalizzata saranno quelli che vinceranno la battaglia per l’attenzione del consumatore.
E tu? Hai già un’ottica omnicanale o stai ancora trattando ogni canale come un’isola separata?
Nei miei percorsi di consulenza uso diversi approcci per avviare una transizione omnichannel nelle aziende, sia quelle comuni che i sistemi in rete, commerciali o Franchising. Spesso, già grazie all’uso della Facilitazione, anche attraverso il Metodo LEGO® SERIOUS PLAY®, si possono delineare obiettivi e processi per arrivare a creare piani di azione solidi, che contemplino rischi e opportunità. Non servono mesi di analisi interne e di mercato per avviare questa transizione, né complessi tool. Se ti interessa iniziare a capire come la tua azienda può diventare omnichannel, mettiamoci in contatto!